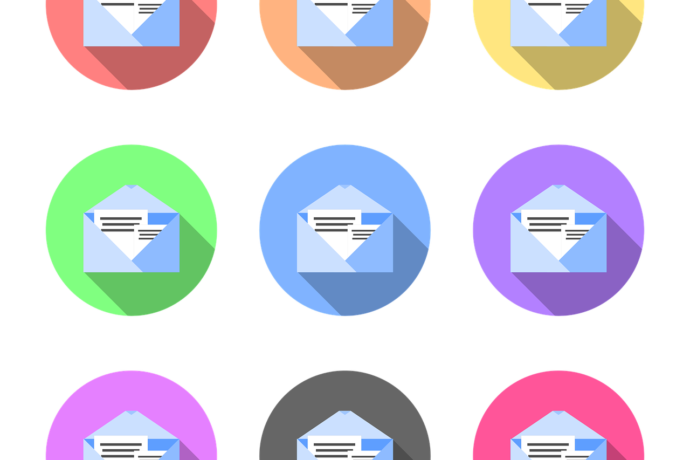19
Lug 2025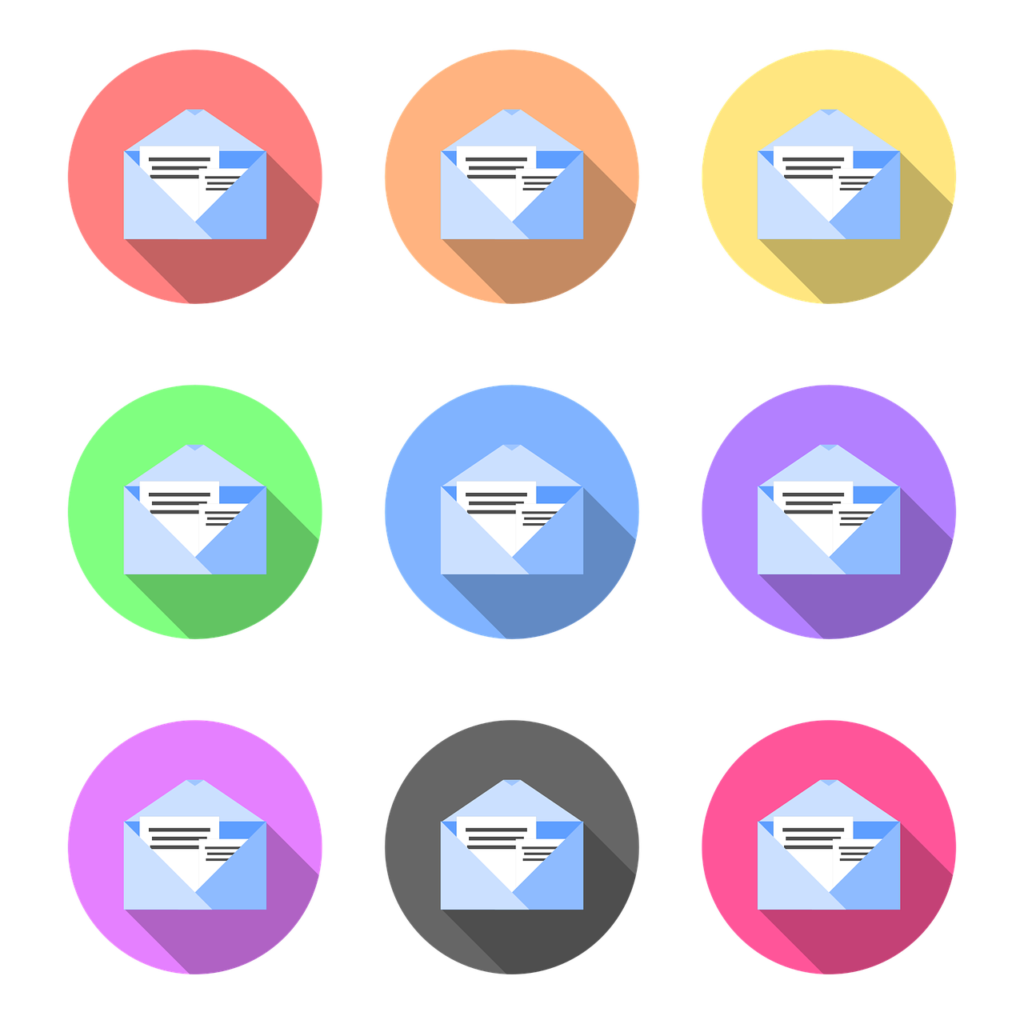
Il fronte dell’acquisizione a fini investigativi e dell’utilizzo a fini processuali del materiale oggetto di messaggistica elettronica istantanea (e-mail, SMS, Whats App e simili) rimane molto caldo, se non altro perché oramai molti reati si organizzano, si commettono e si condividono “messaggiando”.
Dall’ultima volta che ne abbiamo parlato, molta acqua è passata sotto i ponti.
Nel 2023 interviene la sentenza n. 170 della Corte Costituzionale che, pur pronunciata nel particolare ambito del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Senato della Repubblica nei confronti della Procura di Firenze in relazione all’acquisizione di plurime comunicazioni del senatore Matteo Renzi, dà alcune indicazioni di principio molto interessanti.
La Corte dice “in linea generale, che lo scambio di messaggi elettronici – e-mail, SMS, Whats App e simili – rappresenti, di per sè, una forma di corrispondenza agli effetti degli artt. 15 e 68, terzo comma, Cost. non può essere revocato in dubbio”.
“Posta elettronica e messaggi inviati tramite l’applicazione Whats App (appartenente ai sistemi di cosiddetta messaggistica istantanea) rientrano, dunque, a pieno titolo nella sfera di protezione dell’art. 15 Cost., apparendo del tutto assimilabili a lettere o biglietti chiusi”.
E al quesito principale, cioè “se mantengano la natura di corrispondenza anche i messaggi di posta elettronica e Whats App già ricevuti e letti dal destinatario, ma conservati nella memoria dei dispositivi elettronici del destinatario stesso o del mittente”, la Corte dà risposta affermativa: “Degradare la comunicazione a mero documento quando non più in itinere, è soluzione che, se confina in ambiti angusti la tutela costituzionale prefigurata dall’art. 15 Cost. nei casi, sempre più ridotti di corrispondenza cartacea, finisce addirittura per azzerarla, di fatto, rispetto alle comunicazione operate tramite posta elettronica e altri servizi di messaggistica istantanea, in cui all’invio segue immediatamente -o, comunque sia, senza uno iato temporale apprezzabile- la ricezione”.
L’art. 15 della Costituzione, dunque, tutela la corrispondenza, ivi compresa quella elettronica, “anche dopo la ricezione da parte del destinatario, almeno fino a quando, per il decorso del tempo, essa non abbia perso ogni carattere di attualità in rapporto all’interesse alla sua riservatezza, trasformandosi in un mero documento “storico””.
All’atto pratico, questi concetti faticano ad affermarsi compiutamente nella prassi di Procure e Corti, che spesso decidono di volta in volta, senza un indirizzo univoco.
In questo contesto, degne di nota appaiono le “Linee guida in materia di sequestri di telefoni e altri strumenti informatici” licenziate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma.
Si potrà dissentire sulla qualificazione del Pubblico Ministero quale organo amministrativo indipendente equivalente ad un giudice oppure sull’adesione all’orientamento di legittimità che consente il sequestro di dispositivi informatici e la relativa analisi da parte del pubblico ministero senza una preventiva autorizzazione del giudice.
Di sicuro, tuttavia, le Linee guida hanno il pregio di fare il punto giurisprudenziale (anche comunitario) sul tema, di spiegare le ragioni delle scelte interpretative fatte e di dettare modalità operative volte a contemperare le esigenze investigative con le prerogative della difesa.
Poi, per quanti sforzi predittivi si facciano, la realtà è sempre più complessa ed articolata.
In un recente caso di revenge porn finito in Cassazione, l’imputato aveva inviato ad un amico via Whats App la foto delle parti intime della persona offesa; l’amico -nel corso della prolungata conversazione con l’imputato- aveva avvisato la vittima inoltrandole l’immagine e questa aveva consegnato agli inquirenti uno screenshot di quanto ricevuto, screenshot finito agli atti del processo.
La difesa contestava la legittimità dell’acquisizione, sostenendo trattarsi di corrispondenza, che avrebbe dovuto essere sequestrata ex art. 254 c.p.p..
La Corte punta dritta al bene giuridico tutelato dalla costituzione: “lo screenshot ritraente la propria immagine è stato fornito agli inquirenti dalla stessa persona offesa (…). Ne consegue che non viene in rilievo un profilo di segretezza della corrispondenza tutelabile ex art. 15 Cost. poiché lo screenshot non è stato acquisito da soggetti estranei alla comunicazione cui esso si riferisce ma è stato consegnato dallo stesso soggetto che aveva partecipato alla conversazione” imputato / amico.
La stringata ed invero un po’ criptica motivazione rivela la consapevolezza di muoversi su un terreno sdrucciolevole; tant’è che la Corte sente la necessità di confermare il verdetto di colpevolezza dichiarando tutto sommato superflua l’immagine, vista la convergenza in tal senso dell’altro materiale probatorio acquisito nel corso del processo.
La parola fine sulla questione, dunque, sembra non essere stata ancora scritta.